|
PRIMO PIANO

16/10/2024
Il funzionamento del mercato del lavoro
Il mercato del lavoro al quale il legislatore, sotto la spinta politica di vari Governi, almeno in Italia, ha dedicato molti sforzi è una struttura complessa.
Il mercato del lavoro al quale il legislatore, sotto la spinta politica di vari Governi, almeno in Italia, ha dedicato molti sforzi è una struttura complessa. All’interno dell’equilibrio macroeconomico che ogni sistema economico tenta di raggiungere questo particolare mercato è chiamato a svolgere molte funzioni. Il premio Nobel del 1977 James Meade, antico collaboratore di John M. Keynes (avendo fatto parte del Circus dell’Università di Cambridge (UK)), ha chiarito la questione sostenendo che il mercato del lavoro è diverso nel funzionamento rispetto agli altri (quello dei prodotti, della moneta e delle attività finanziarie (titoli in particolare)) perché è chiamato a svolgere troppi compiti nello stesso momento. Più precisamente è chiamato ad occuparsi della funzione allocativa, di quella assicurativa, di quella distributiva ed in ultimo di quella informativa (della quale per motivi di spazio non ci occuperemo). Ma chiariamo meglio. Quando James Meade iniziò le sue riflessioni la vulgata pensava che il mercato del lavoro svolgesse essenzialmente una funzione allocativa: determinando un salario che avrebbe consentito l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ma secondo l’economista inglese sul salario gravano altri compiti e ne segnala due: quello assicurativo e quello distributivo. La funzione assicurativa è preferita per il fatto che, per molti dei lavoratori, il salario rappresenta l’unico reddito percepito e la fonte del proprio reddito futuro. Con la conseguenza che i lavoratori stando così le cose ricercano la stabilità del salario nel tempo e questo li porta a legarsi con contratti a lungo termine (a tempo indeterminato e/o determinato). La funzione distributiva dipende, invece, dal potere contrattuale che ha il singolo lavoratore e scaturisce da quanto quest’ultimo sia sostituibile. Un conto ad esempio è essere un neurochirurgo di fama o un bracciante agricolo: col primo che riesce ad ottenere una fetta maggiore della torta del reddito prodotto a cui contribuisce rispetto al secondo. A livello macroeconomico, poi, la sostituibilità dei lavoratori aumenta nelle fasi di disoccupazione elevata e prolungata. In questi casi il lavoratore ha un potere distributivo basso ed i contratti in scadenza vengono rinnovati in ritardo e a livelli più bassi di salario. Riassumendo: i lavoratori preferiscono non affidare al mercato del lavoro la determinazione del livello di salario ma si servono di quest’ultimo per compiti di assicurazione e di distribuzione del reddito. Sacrificando insomma la funzione allocativa. Consapevole di questo dato di fatto James Meade ritiene che per consentire al mercato del lavoro ed al salario di svolgere la funzione allocativa, quella assicurativa deve essere rimessa alle Istituzioni del Welfare State attraverso gli ‘ammorizzatori sociali’. Mentre quella distributiva deve essere affidata alla distribuzione della ricchezza e della proprietà regolata dagli interventi dello Stato attraverso la politica fiscale ed i trasferimenti. Il mercato del lavoro deve essere lasciato al suo libero funzionamento. Quelle che occorrono piuttosto sono le politiche attive del lavoro e di sostegno (praticato attraverso il welfare come suggerisce Meade) dei lavoratori all’interno del mercato del lavoro, e parimenti politiche che generano opportunità di lavoro. Contrattazione decentrata a livello aziendale e flessibilità riducendo i costi del licenziamento (firing cost). Sussidi di disoccupazione quasi dello stesso ammontare dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore accompagnati da processi di formazione. In questo modo diminuirebbero le resistenze al cambiamento ed il conflitto tra capitale e lavoro. Croce e delizia delle relazioni industriali italiane a partire dal secondo dopoguerra. In proposito potremmo seguire l’esempio del Regno Unito. I lavoratori d’oltremanica ricevono se disoccupati una sorta di reddito di cittadinanza unito ad una NASPI sui generis. Se trovano un lavoro che gli garantisce un reddito al di sotto di una certa soglia stabilita ricevono una integrazione salariale per raggiungerla. In questo modo vi è un incentivo da parte delle persone a cercare lavoro, generando un sostituto d’imposta, e a migliorare la propria esistenza. Naturalmente queste ricette a volte non funzionano per le caratteristiche anagrafiche delle persone o per le competenze che hanno. In un prossimo articolo ci occuperemo degli strumenti messi in campo in Italia per svincolare il mercato del lavoro dalla funzione assicurativa. Ed in particolare del reddito d’inclusione (REI), del reddito di cittadinanza (RDC) e della misura di integrazione attiva (MIA). Ma una cosa va chiarita sin da subito. L’errore che è stato compiuto in Italia è stato quello che ogni Governo ha voluto creare un nuovo strumento invece di correggere le storture di quello ereditato dal precedente esecutivo. Nelle scienze sociali contrariamente a quelle fisiche, in effetti, non è possibile testare in laboratorio (prima dell’introduzione) l’efficacia delle politiche sociali. Queste ultime mostrano i loro pregi e difetti solo dopo l’implementazione. In altre parole i Governi Giallo-Verde, Giallorosso, Draghi e Meloni avrebbero dovuto correggere le storture ed i malfunzionamenti delle misure introdotte col REI e col RDC e non crearne di nuovi. Gettando alle ortiche i dati raccolti e le analisi sulle pratiche osservate fino a quel momento.

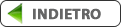
|