|
PRIMO PIANO

22/10/2024
La necessità dell’introduzione di un Reddito di Base Incondizionato
Come pesante eredità della Prima Repubblica l’Italia ha sempre avuto un welfare basato su pensioni generose, incluse quelle di invalidità concesse il più delle volte con magnanimità, sul dilatamento delle assunzioni nel pubblico impiego (co
Come pesante eredità della Prima Repubblica l’Italia ha sempre avuto un welfare basato su pensioni generose, incluse quelle di invalidità concesse il più delle volte con magnanimità, sul dilatamento delle assunzioni nel pubblico impiego (coi casi eclatanti dei forestali), sulla cassa integrazione in deroga, e su altalenanti politiche sociali locali ecc.. Un welfare arlecchino per utilizzare una terminologia coniata dal sociologo Luca Ricolfi. Comunque un sistema di assistenza molto diverso rispetto a quelli prevalenti nella quasi totalità dei paesi europei. Il primo tentativo per avvicinarsi alle buone pratiche del Nord Europa è stato l’introduzione del Reddito di Inclusione (REI) nel maggio del 2017. Dopo venti anni dalla pubblicazione dei lavori della Commissione Onofri che nel 1997 proponeva un reddito di base nazionale ispirato ai modelli europei, il suo utilizzo è stato il primo vero (anche se piccolo) passo verso quell’obiettivo. Il REI si inserisce nel solco, che è anche quello europeo, dei trasferimenti condizionati dello Stato verso i cittadini: per riceverli, (i) bisogna avere un reddito o una ricchezza inferiore ad una certa soglia, (ii) è necessario partecipare a varie attività che segnalano o migliorano la propria disposizione a lavorare o a guadagnare di più. I trasferimenti diminuiscono o terminano dopo un lasso di tempo prefissato. Nel corso di molti decenni, i paesi che hanno adottato un simile approccio hanno incontrato, insieme al beneficio, anche i problemi connessi all’introduzione. In presenza di un trasferimento condizionato legato ad una soglia del reddito che non deve essere superata, in effetti, coloro che lo percepiscono hanno un incentivo a non superare il limite stabilito, a lavorare di meno o anche a non lavorare, in particolare se il salario che si aspettano di guadagnare sul mercato del lavoro è basso. Inoltre, hanno un incentivo a praticare il lavoro nero e ad occultare la ricchezza posseduta. Nel nostro Paese per motivi culturali, organizzativi ed economici, questo incentivo si è rivelato notevole. In ultimo, considerato che l’accertamento del diritto a ricevere il trasferimento e del rispetto di tutte le condizioni richieste, il controllo dei comportamenti sleali, la gestione dei contenziosi ecc. ha comportato costi ingenti sia per i percettori che per lo Stato questo ha modificato negli anni i criteri adottati. Vi sono stati col passare del tempo tagli ai trasferimenti, incentivi al lavoro (in-work benefits, crediti fiscali), condizionamenti più sofisticati o altri correttivi. Il dibattito in Italia dall’introduzione del REI, dalla trasformazione in Reddito di Cittadinanza (RdC) ed in ultimo nella Misura di Inclusione (MIA) è stato caratterizzato da confusione, ignoranza e stereotipi. Questi strumenti hanno avuto in parte successo, ma hanno anche aumentato i costi del sistema, sia direttamente (es. i crediti fiscali costano) sia indiretta (più controlli, più incentivi a cercare di aggirare le regole). Anche per questo, recentemente è cresciuto l’interesse per una direzione di riforma diversa da quella imboccata a partire dalla fine degli anni ’970 e che ha condizionato anche la tardiva introduzione in Italia a partire dal 2017. Secondo alcuni addetti ai lavori e anche alcuni politici si tratterebbe di provare a spostarsi verso politiche più universalistiche e meno condizionate, al limite verso un sistema di Reddito di Base Incondizionato (RBI). L’interesse per percorrere questa strada ha poco o nulla a che fare con l’assistenzialismo o il populismo ma molto invece con l’efficienza. Molti pensano all’equità ma senza l’efficienza si va poco lontano. Tutto il sistema di controllo e di inserimento al lavoro previsto in primis dal REI, poi dal RdC ed in ultimo dal MIA è stato ed è molto pesante e forse persino più costoso dell’intero ammontare del trasferimento. L’attenzione esclusiva rivolta alle famiglie in povertà assoluta corre il rischio di generare effetti ‘stigma’ ed impatta su realtà come il Mezzogiorno d’Italia dove gli incentivi e le opportunità di lavoro nero sono forti. Per aggirare questi problemi bisognerebbe introdurre una Imposta Negativa sul Reddito (qualcosa di intermedio tra i trasferimenti condizionati puri e RBI) di friedmaniana memoria: una regola generale valida per tutti i cittadini (il sussidio deve essere per tutti) con dimensioni realistiche, coperture certe, bassi costi amministrativi, e buoni incentivi al lavoro. Ma di questo ci occuperemo nel prossimo ed ultimo articolo dei tre dedicati all’argomento.

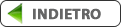
|